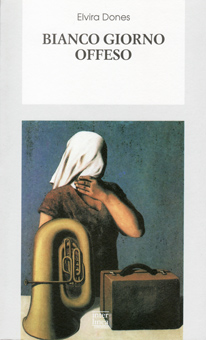Bianco giorno offeso
(romanzo, traduzione dall’albanese di Elvira Dones,
Interlinea edizioni, Novara, 2004)
La quarta di copertina:
Dopo il successo di “Sole bruciato” (Feltrinelli) Elvira Dones torna con un romanzo forte e doloroso che ha per protagonisti un profugo albanese in Svizzera e un amico dalla straordinaria vitalità mal incanalata e controcorrente. E’ il racconto della profonda e tormentata amicizia tra i due uomini, attraversata da altre passioni, struggenti e impossibili perché così è la vita e perché i personaggi sono in balia della storia. Un romanzo intenso, appassionante, vero.
Le prime pagine:
Mi chiamo Ilìr Bejko. Il mio amico si chiama Max Baumann e io non so che pesci pigliare. Mi trovo davanti a una pagina bianca, tutta da scrivere. Sono due ore che mi scervello masticando inizi di racconto come fossero paglia e io un cavallo che gira in tondo. Anche se non devo inventare nulla. Che lo voglia o no, ciò che è successo è successo. La storia mi sta rannicchiata nello stomaco sfiancato dall’ulcera che deve aver cominciato a torturarmi sin da quando stavo in grembo a mia madre, e forse anche prima.
E’ una giornata in apparenza tranquilla, una di quelle giornate che non ti asfissiano con mille piccoli compiti tipo rifornire di cibarie il frigorifero vuoto, portare dall’unico calzolaio della città le scarpe rotte, e altre cose così.
E’ una giornata libera da obblighi banali, e proprio qui sta la sua perfidia. Non ti lascia nemmeno un pertugio per tentare la fuga.
“Racconta un giorno, quando avrai tempo,” mi pregò Max, “con calma, senza fretta, capisci?”
Annuii molto arrabbiato, e arrabbiato non è proprio la parola che ti dia l’idea della bestiale incazzatura che mi ero pigliato quel giorno.
Dubito che si rendesse conto del peso che mi stava buttando addosso con quella richiesta. Dubito che capisse che così mi stava condannando a una sofferenza ancor più grande di tutto ciò che pativo dentro di me da secoli. Ma questo era Max, e non poteva cambiare. Se non fosse stato così, oggi sarebbe rimasto impigliato lui nella propria storia, invece di gettarla su di me come una rete in mare aperto, e io a fare il pesce, l’unico pesce, che apre la bocca per un filo d’ossigeno, l’ultima molecola prima di abbandonarsi per sempre alle umide mascelle della trappola.
“Sono stanco,” annunciò Max come se solo lui avesse il diritto alla stanchezza. Come se l’umanità intera non fosse stanca di tutto, e io non fossi stanco e non avessi anch’io voglia di dire ciò che lui si sentiva in diritto di proclamare: sono stanco, amico.
“Sono stanco, e tu racconterai questa… cosa, questa vita, quest’amicizia. La racconterai, amico.”
Non mi chiamava per nome da settimane, ma solo “amico”, come per provare a se stesso o a me il fatto che, giacché ero amico, giacché tale mi considerava, questo doveva servire da amo e io avrei afferrato il filo della storia per tesserla fino in fondo.
“Racconterai tutto ad Alex.”
Mi trafisse con lo sguardo.
Era un giorno sbiadito. Il sole era bianco. Bianche anche le nuvole che lo circondavano senza osare coprirgli il volto. Persino il cielo era bianco. Max indossava una camicia bianca su jeans azzurri, stretti attorno all’esile silhouette. L’ampia camicia di lino, le maniche rimboccate fin sopra i gomiti, i bottoni slacciati sul petto abbronzato dal sole di quel luglio bislacco.
Non so perché, ma lo guardai intensamente, con occhio da fotografo, e mi resi conto che Max era un bel tipo. Non che questo non l’avessi già sentito dalle ragazze che gli ronzavano intorno, o da Alex, ma non ci avevo mai fatto caso.
L’avevo già osservato, Max. Lungo quei due anni di amicizia avevamo trascorso molto tempo insieme: secche notti d’inverno, notti ubriache per le strade deserte di Lugano, notti disperate quando io vegliavo su di lui che non mi mollava la mano e mi chiedevo che ci faccio qui, nel cuore della notte, con questo bietolone d’uno svizzero che dorme della grossa mentre a me tocca fare diana all’alba per guadagnarmi la pagnotta. Ma non l’avevo mai analizzato, nel senso estetico della parola. Non so perché me ne resi conto solo in quell’istante: Max era bello, aveva ragione Alex. Con quei capelli color grano maturo, corti, le orecchie appiccicate alla testa, un filo di barba appena accennata, appena visibile.
“Se mi radessi a filo sembrerei… Come dici tu nella tua lingua?”
“Zullap.”
Aveva un rasoio di quelli che costano un occhio.
“Esatto, zullap. Il segreto sta nel dettaglio, un millimetro in più e sei a posto, uno in meno e sembri un idiota. Il segreto della bellezza in questo mondo sono i dettagli, non il totale, che fa vomitare. Allora, racconterai ad Alex tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi?”
Alex era partita per la Nuova Zelanda. Come potevo raccontare a una che, per scappare via da Max, s’era scavata un tunnel sotto i piedi e aveva trivellato la via di fuga fino a sbucare in Nuova Zelanda? Come potevo io raccontare ad Alex gli ultimi giorni? Dove trovare tutte quelle parole? Io ero un semplice pizzaiolo, facevo pizze e basta. Ero anche un po’ falegname e un po’ muratore. Ero anche un eterno profugo. Ma quest’ultima caratteristica non mi regalava il talento di raccontare. Tutt’al più mi muniva di una certa capacità di osservazione, cosa che solo da poco avevo scoperto in me.
Ma per tornare a quel giorno.
Max aveva cacciato le mani nelle tasche dei jeans, e il bianco un po’ lugubre della giornata dava al blu dei suoi occhi un che di smunto.
Il suo vero nome era Massimo. E Alex in realtà si chiamava Alessia. Da questa parte dell’Europa avevano l’abitudine di abbreviare i nomi italiani o mediterranei dando loro un accento nordico, prussiano, celtico o qualcosa del genere. Suoni dolci assumevano così sapori vagamente militareschi: Alessia diventava Alex, Francesco si troncava in Franco o Frank, Michele in Mike che, peggio ancora, pronunciato alla tedesca con la h finale, ti strappava fuori le tonsille. Ma queste sono cose soggettive, forse solo io le vedevo così, data la mia diversa sensibilità linguistica.
Max mi fissò, a lungo, in silenzio, nonostante quella fosse una giornata da parlare finché la lingua non ti diventava cenere.
Era un giorno da parole, quello, eccome!
Potevi parlare senza avere bisogno di farti comprendere, senza nemmeno dover tirar fuori passaporti e chiarire: vengo da quel tormento, vengo da questa gioia. Potevi parlare tranquillo e certo che il mondo ti avrebbe capito. Tutti gli inferni e tutti i paradisi, sotto il soffice e piumoso mantello di quel cielo, erano ugualmente raccontabili. Ma noi due mancammo quell’opportunità e continuammo a fissarci lungamente, in silenzio, e il silenzio inghiottì tutto quanto nel suo ventre profondo come l’oceano in cui era sparita Alex.
Poi Max mosse la mascella e io mi protesi in avanti per facilitargli il parto di quei suoni tanto difficili. Lui non partorì alcunché. Entrambi volgemmo lo sguardo al lago di Lugano. Le barche, cariche di turisti arrossati, vagavano senza indirizzo. Le voci arrivavano fino alle nostre orecchie. Non conoscevo la lingua, ma sapevo benissimo distinguere il dialetto svizzero-tedesco dal buon tedesco. Non per niente vivevo in Svizzera da cinque anni. Mi venne sonno. Mi voltai verso Max.
“Ciò che mi aspettavo che accadesse è ormai passato, amico”, disse lui finalmente. “Io… speravo che qualcosa entrasse nella mia vita.”
Contemplò ancora attorno a sé. Un cigno ci stava passando a fianco maestoso, luccicante d’acqua. Max tirò le mani fuori dalle tasche e lasciò cadere le braccia lungo i fianchi come un bambino timido e impacciato.
“Mi aspettavo che qualcosa venisse a bussare, ma se n’è andato prima ancora di essere arrivato. Se n’è già andato, amico. Ormai se n’è già andato.”
“Non è vero,” dissi.
“Cosa?”
“Che è già passato ciò che stavi aspettando. Sta parlando solo la tua disperazione.”
“E’ un bel po’ che… è da un pezzo, capisci?”
Non capivo, ma dall’esperienza sapevo che non mi avrebbe aiutato a capire. Quindi rinunciai. Attesi che aggiungesse qualcos’altro, e mentre attendevo il cuore cominciò a striminzirsi come uno straccio bagnato.
“Perché non dici niente?” provò a stuzzicare Max.
“E che dico?”
“Qualcosa, quello che vuoi.”
“Mjaft, Maks, se po më shqetëson.”
Gli avevo detto che mi stava preoccupando. Lui non capì e questo lo irritò. Tradussi.
“Ah,” disse, “ti sto preoccupando, eh?”
Provai un gran desiderio di essere lontano. Ci sarebbe stato un buco in cui potersi rifugiare, stare lontano dal mio paese, lontano anche da questa terra dove vivevo da anni e che ancora non si era decisa ad accettarmi. Chi l’aveva detto che era necessario vivere con i ricordi, i dolori, le gioie e altre cazzate del genere? Non si poteva vivere e basta? Senza niente. Sarei stato felice di poter vivere senza niente.
“Che stai pensando?” si incuriosì Max.
“E’ un po’ complicato, non saprei spiegarlo.”
“Tu provaci.”
“Muoviamoci, su,” dissi con voce implorante, “è mezz’ora che stiamo qui come chiodi arrugginiti.”
“Perché arrugginiti?”
I suoi occhi stavano diventando cattivi, provocatori, con quello sguardo avevo avuto a che fare molte volte nell’ultimo anno.
“Max, sono stanco.”
“Anch’io, amico.”
“Dai, chiamami per nome, basta adesso.”
“Perché, amico, ti disturba?”
Presi a camminare velocemente verso il parcheggio dove avevo lasciato il catorcio, cercando di controllare l’improvviso affanno. Lui mi seguì. Respirava con difficoltà, ma non mi voltai, proseguii finché l’umidità dell’aria mi appesantì i polmoni come una pentola a pressione. Quando mi arrestai, lui stava salutando qualcuno. Rimasi fermo. Mi si accostò.
“Scusami, non so che mi ha preso. Posso venire con te?”
“No.”
“Mi fai prendere il bus con questo caldo?”
“Affar tuo.”
“Ci vedremo stasera?”
“Non credo proprio, Max,” dissi.
Ora eravamo sotto le mimose lungo la strada, poco prima del parcheggio sul delta del fiume, nel quartiere di Cassarate.
“Ti prego,” disse.
“No.”
Stavolta la mia voce fu talmente cruda che il suo animo sensibile non poteva non risentirsi. Infatti non insistette.
Ora so che se Max mi avesse pregato ancora una volta, io avrei acconsentito a regalargli altre notti e altri giorni, in una faticosa catena di confessioni che ormai già conoscevo a memoria.
Ma in quel momento mi mostrai irremovibile. Forse per la prima e ultima volta nella mia vita, fui determinato. Che sia stata l’unica volta sbagliata? l’unica in cui non avrei dovuto mostrarmi tanto intransigente? Se forse quella sera fossi andato a incontrarlo, l’indomani sarebbe stato diverso? Lui mi piantò l’indice sul petto.
Aveva mani da pianista, con dita lunghe, forti, nervose. Max mi aveva fatto la testa come un pallone con registrazioni di concerti per piano e racconti minuziosi sull’arte del pianoforte, cosa che mi aveva aiutato a farmi un’idea sulle mani dei pianisti. Cécile Baumann era pianista. Aveva le stesse mani di Max, ma in versione femminile. Dall’ultimo concerto tenuto a New York aveva spedito al fratello una foto delle sue mani in primo piano. Sul dorso della foto Cécile aveva scritto: “Mi manchi, vorrei metterle sulle tue spalle, mi mancano le tue spalle, fratellone”.
Affondando il dito nelle costole, Max disse:
“Promettimi che racconterai, per Alex e per Cécile, okay?”
“E piantala con ‘ste stronzate ché mi hai rotto.”
Max rimase sospeso a mezz’aria e un attimo dopo gli si accesero gli occhi.
“A che ora finisci stasera?”
“Come sempre, alle due.”
“A New York le nostre due del mattino sono le otto di sera.”
“E allora?”
“Allora vuol dire che Cécile potrebbe essere a casa e tu le puoi mandare una mail da parte mia.”
Mi strofinai le palpebre per tirarmi in quadro.
“Ci scrivi tu a Cécile, io cosa c’entro?”
“Dai, non fare finta di non sapere.”
Max scoppiò a ridere. “Stiamo straparlando,” disse poi, mentre gli occhi gli si stavano riempiendo di lacrime.
“Vado, Max, mi devo cambiare e correre al lavoro.”
“Scriverai a Cécile?”
“E va bene.”
“Stammi bene, amico,” mi disse e mi si buttò tra le braccia.
“Non capisco dove vuoi andare a parare, Max Baumann,” dissi, e mi staccai, sentendo nelle dita la voglia che avevano le sue spalle di non allontanarsi dall’abbraccio. “A volte sembra che ti manchi sul serio una rotella. Ci vediamo domani pomeriggio, va bene?”
“…”
“Domani mattina non venire a svegliarmi ché sarò morto, ma nel pomeriggio usciamo a bere qualcosa.”
“Nel pomeriggio non potremo vederci,” disse con lo sguardo altrove.
Mi avviai, e camminando udii il rumore delle carni della mia anima fatta a pezzi, brandelli che mi rincorrevano nella speranza di salvarsi dalle fauci di questa cosa chiamata vita. Sentivo d’aver perso. In quel momento desideravo solo fuggire dal mio fallimento.
Scappai via, facendo roteare in aria le chiavi dell’auto agganciate al grande mazzo che teneva assieme quelle della pizzeria, quelle dell’appartamento, la chiave del locale lavanderia nella cantina del condominio, quella della piscina coperta che pulivo durante il fine settimana per arrotondare lo stipendio.
Max mi seguì ancora.
Un furgone della Croce Verde lanciò all’improvviso una sirena che sbraitò per le strade con la furia di una donna isterica.
Al parcheggio mi attendeva una multa sul parabrezza.
“Al diavolo!”
“Racconta la storia in prima persona, Ilìr, come se tu fossi tu e tu fossi io.”
“Tu hai la febbre, te lo dico io. Non la bevo, non ne posso più, di te ne ho piene le palle.”
Vattene, mi dissi, che aspetti a squagliartela una volte per tutte da questo pazzo, da questa città, da questo cantone, da questo paese, da questo continente, da questo cielo, da questa galassia? Perché non molli tutto, anche te stesso?
Ma restai lì, fermo come uno zombie.
Max per un attimo assunse una postura definitiva, razionale, che lo avvolse dell’autorità d’un professore di matematica.
“Ora mi levo dai piedi, te lo giuro, ma in prima persona, non dimenticare!”
“Basta che adesso smammi, eh. E la tua merda te la racconti da solo, in tutte le voci e le persone che vuoi, perché a me basta e avanza la mia.”
Saltai in macchina e accesi il motore abbassando allo stesso tempo il finestrino. Ingranai la retro, ma Max non si schiodava e io non potevo muovermi senza urtarlo con la fiancata dell’auto.
“Spostati.”
“Ti ricordi il Concerto per pianoforte che ti ho regalato un mese fa?”
“Sì, Brahms o qualcosa del genere.”
“Concerto in re minore, opus 15.”
“E poi?”
“Ascoltalo domani sera.”
“Ragazzo, tu la stai tirando per le lunghe, io devo andare a lavorare.”
“Allora buona giornata.”
“Già. E non fare idiozie oggi, ché non ho voglia di doverti correre dietro.”
“Va bene, mamma.”
“Mamma di tua madre.”
Max rise. Alla fine si spostò e io potei uscire dal parcheggio. Ci separammo così. Quelle furono le ultime parole che ci scambiammo in questa vita. Lo osservai nello specchietto retrovisore rimpicciolirsi fino a sfumare nel bianco sconfinato di quella giornata da dimenticare.
Per ordinare BIANCO GIORNO OFFESO puoi scegliere una delle seguenti librerie in rete: